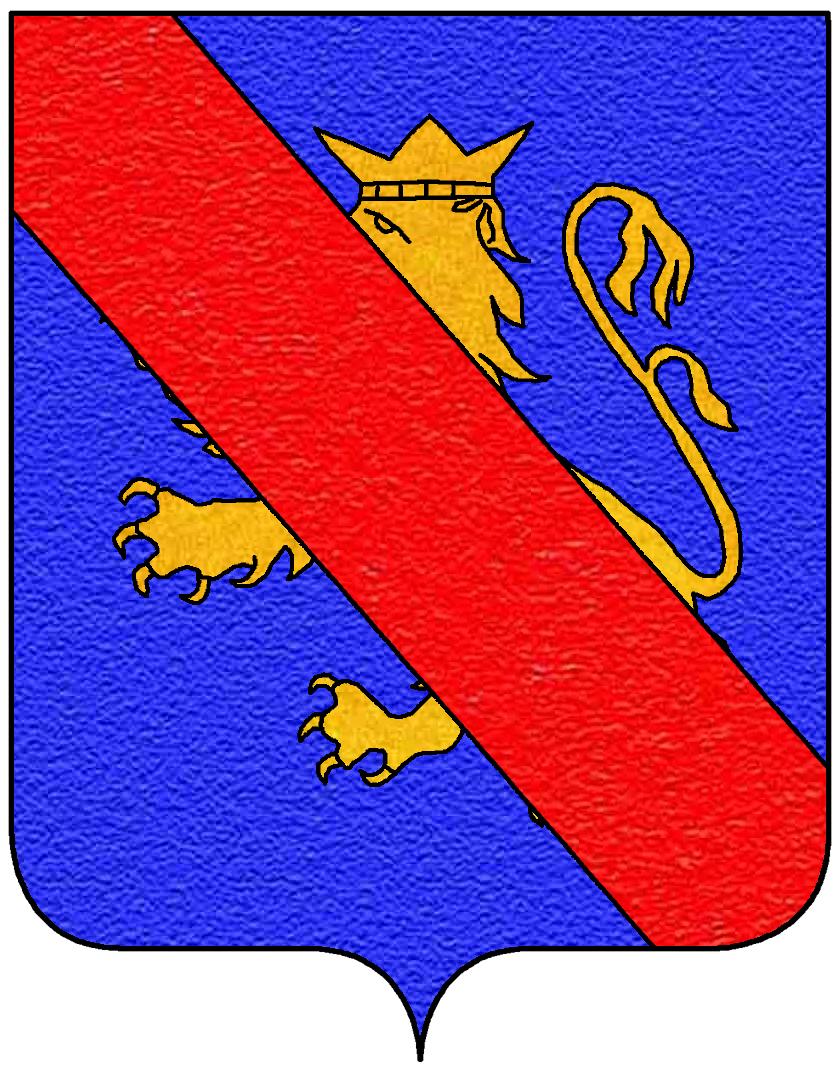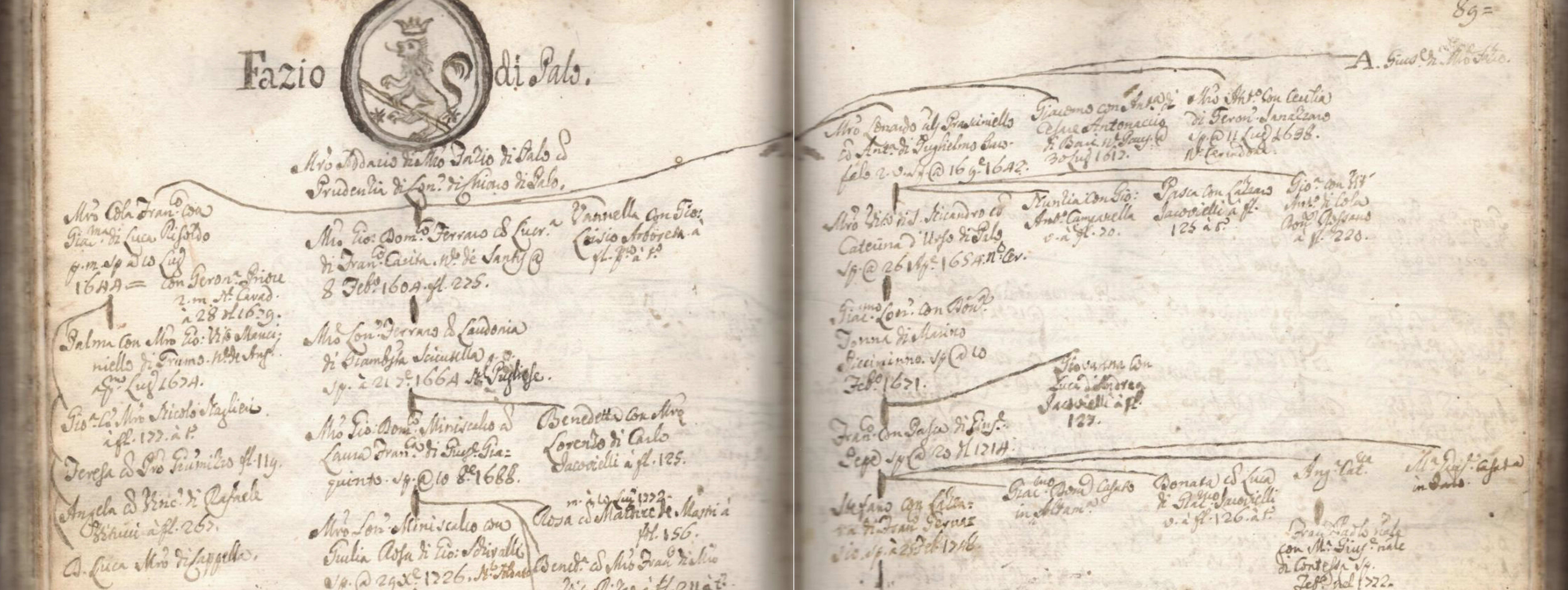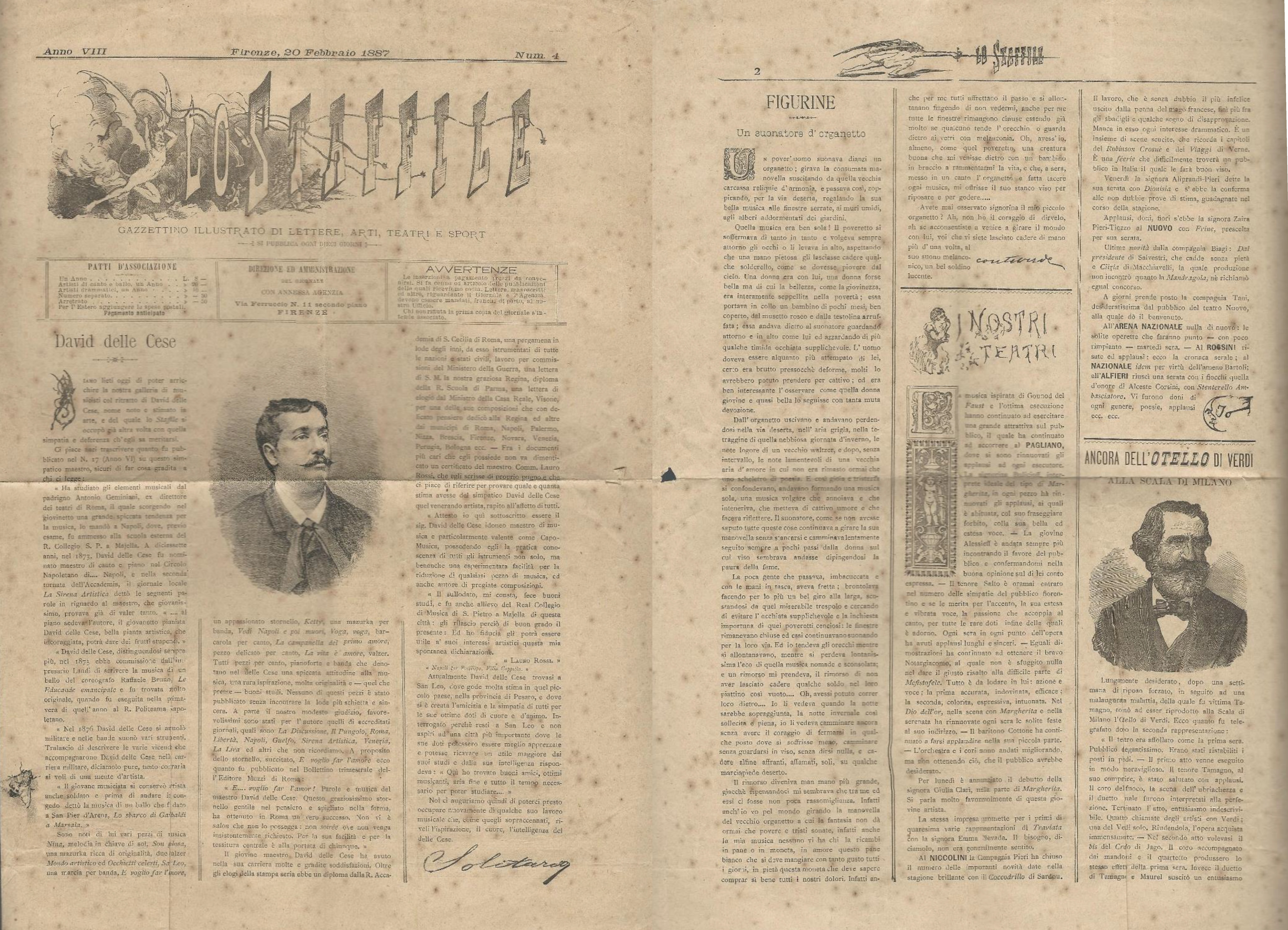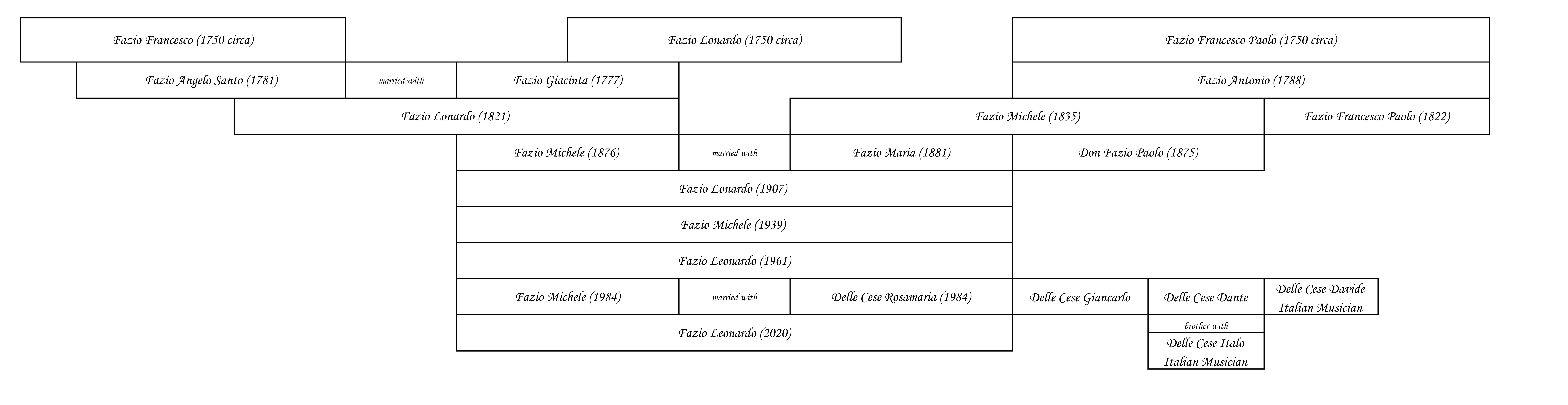
la storia della famiglia fazio di bitettO
I contenuti riportati in tale pagina sono frutto di una mia personale ricerca. La storia della famiglia Fazio viene spesso collegata a quella del Re Federico II di Svevia, il cui maestro di palazzo era Fazio Giovanni. L’incarico di maestro di palazzo consentiva, a chi ne veniva investito, di avere un potere pari quasi a quello del proprio signore: ne era il consigliere personale, assisteva alle udienze, ne svolgeva le veci in caso di assenza, di malattia, o di morte (in attesa dell’investitura del successore). Grazie a questa grande libertà di azione, con l’andare del tempo i maggiordomi o maestri di palazzo assunsero un potere via via crescente, sia in ambito politico sia amministrativo, arrivando a occuparsi, in vece del sovrano, di tutte le attività politiche e militari, fino in alcuni casi a sostituire lo stesso Re. Un esempio noto di maestro di palazzo è stato re Pipino Il Breve, padre del futuro imperatore Carlo Magno. Una delle ricerche in fase di svolgimento è quella relativa ad un eventuale legame con Castel del Monte, che ha portato la famiglia a spostarsi da Castel del Monte a Terlizzi (dove sono presenti atti riportanti il cognome de Fazio del 4 Marzo 1264, vedasi il Codice Diplomatico Terlizzese e l'atto di donazione di Churamaria figlia del maestro Basilio di David de Fazio), per poi proseguire a Palo del Colle con gli Sforza e infine a Bitetto. Sebbene si stia seguendo tale ipotesi, mentre il cognome riportato nel Codice Diplomatico Terlizzese è "de Fazio", negli atti notarili del notaio Pausitano, il capostipite del ramo bitettese viene riportato come Leonardo de Facii. Un dato certo è che viene marcatamente individuata la dicitura di Maestro sin dal XIII secolo, sia nell'albero genealogico sia negli atti notarili, affiancata ad una assenza totale di titoli oggi presenti nel nostro contesto sociale (come ad esempio dott., ing., arch., avv., prof.). Il più antico Maestro costruttore noto, di cui non vi è evidenza di eventuale discendenza nonostante la dicitura riportata sia identica, è Lanfranco de Facii (1085 dC), architetto maestro costruttore conosciuto per aver realizzato il Duomo di Modena, collegato ai maestri comacini (già riportati nell'Editto di Rotari nel 643 dC). La dicitura "comacini" tende ad essere associata più alla definizione cum machinis o cum macinis riferendosi alle impalcature e argani che questi artigiani utilizzavano nella costruzione delle loro opere che ad una eventuale provenienza da Como. Negli atti del 1636 il capostipite del ramo bitettese viene riportato come Maestro Lonardo de Fazio nell'indice e magister Leonardo de Facii nell'atto. La professione prevalente svolta nel XVII secolo è quella del fabbro e del maniscalco, cui si aggiunge anche quella agricola. A conferma di ciò infatti vi è prova del fatto che a fine XVII secolo, la famiglia aveva già propri poderi, in quanto risulta la donazione di un podere effettuata da Laudonia Fazio, figlia di Giovanni Domenico Fazio di Lonardo Fazio (sposato con Laura Giaquinto), devota della Benedetta, affinchè il frutto di tale podere si dividesse tra gli assistenti alla Messa cantata durante il giorno festivo (notaio Pesce - 1735). Non si è a conoscenza di eventuali parentele con il pittore Corrado Giaquinto, nonostante il contestuale periodo, sebbene sia tramandata la presenza di tre pitture di illustri artisti poi non più presenti all’interno della stessa chiesa (Vitetum* - Cronologia dei Vescovi Bitettesi*). La zia di Laudonia Fazio, Benedetta Fazio, era madre di don Riccardo Iacovelli, scrittore attivo nel XVIII secolo, noto per la Cronologia dei Vescovi Bitettesi, oltre per l’elaborazione dell’albero genealogico in allegato, parte di un'opera più ampia, definita come "Libro dei nati" riportata nelle trascrizioni della stessa Cronologia dei Vescovi Bitettesi. Questo lascia supporre che il riporto dello stemma, così come raffigurato, sia attendibile, in quanto trasmessogli dalla madre. Gran parte dei territori della famiglia Noja furono rilevati dagli stessi Fazio, di fatto divenendo nel XIX secolo, una delle principali famiglie latifondiste del paese assieme alla famiglia Abbruzzese. Numerosi sono anche i notai, medici e preti a partire dalla fine del XVIII secolo sino ai tempi odierni.
Analisi di carattere generale ritengono che si sia avuta l’introduzione della famiglia nel sud Italia (Sicilia e Campania e ipoteticamente Puglia) da Pavia con l’imperatore Federico II di Svevia, mentre parallelamente vi era una espansione della stessa da Pavia in Liguria, vedasi gli esempi di Bartolomeo Fazio e Giovanni Battista Fazio (parenti – XV secolo) oltre ad una generale espansione legata all'attività dei maestri. I tre percorsi al momento in fase di approfondimento sono i seguenti: 1. arrivo in Puglia con l'imperatore Federico II probabilmente per la gestione del cantiere di Castel del Monte; 2. arrivo in Puglia da Napoli con il Ducato di Bari; 3. arrivo in Puglia da Milano-Genova con il Ducato di Bari. L'ipotesi della provenienza da Milano-Genova potrebbe nascere dall'episodio della congiura ai danni di Bona di Savoia da parte di Sforza Maria (che si rifugiò a Palo del Colle nel 1477 avviando un importante scuderia e allevamento di cavalli, da cui trae origine la tradizione del Palio del Viccio, tuttora presente). Molto difficile è recuperare informazioni sul periodo di Palo del Colle essendo totalmente assente presso l’Archivio di Stato di Bari la documentazione relativa ai notai di Palo del Colle del periodo 1476 – 1610.
A rafforzare l'ipotesi della provenienza da Napoli e da Bartolomeo Facio invece si colloca la Congiura dei Baroni, con il primo scontro avutosi nel periodo 1459 – 1464 d.C., e il secondo scontro avutosi nel periodo 1485 – 1486 d.C. . L’evento viene ricordato tuttora nel corteo storico medioevale che si tiene a Bitetto ogni anno. Andrea Matteo III Acquaviva, i cui territori comprendevano all’epoca sia Bitonto che Bitetto, fu membro dell’Accademia Pontaniana, fondata da Antonio Beccadelli, detto “Il Panormita”, il quale aveva stretti rapporti con Bartolomeo Facio. Sebbene venga individuato al 1458 d.C. l’anno di fondazione dell’Accademia Pontaniana (anno successivo alla morte di Bartolomeo Facio), molti individuano come anno effettivo di nascita dell’Accademia il 1442 d.C. , anno in cui Alfonso I d’Aragona, all’indomani dell’investitura a re di Napoli, allestì nella sua casa di Castel Capuano una ricchissima biblioteca (poi trasferita al Castel Nuovo) dove si riunivano uomini di cultura per discutere di letteratura e filosofia, tra cui Bartolomeo Facio. Andrea Matteo III Acquaviva è stato anche docente presso la stessa accademia.
La presenza della famiglia Fazio nell’area di Bitetto è ufficialmente documentata sin dai primi anni del XVII secolo (come da albero genealogico in allegato, prodotto nel XVIII secolo), come produttori di olive, sia da olio che da tavola, proprietari terrieri, commercianti di olive e proprietari di frantoi, con una forte devozione cattolica strettamente correlata alla Confraternita della Madonna del Rosario, fondata nel 1666, e all’annesso Convento dei Domenicani. Il mio trisnonno ha avviato un frantoio nel 1924, il più antico del paese e tuttora esistente. Il ns ramo familiare ha preferito occuparsi prevalentemente di produzione di olive, per poi transitare all’attività artigianale di imbottigliamento e commercializzazione avviata nel 2019.
La famiglia Fazio è un punto di riferimento nella storia della produzione olivicola locale, sia olive da tavola che da olio, da oltre quattro secoli, anche grazie alla vocazione del territorio. La tradizione è legata alla produzione e al commercio di olive ed olio d’oliva, ed è stata tramandata fino ai tempi odierni. La storia si interseca con cultura, tradizione e religione.
La famiglia viene ritenuta originaria di Pavia (Mugnos*). La storia di Pavia si interseca tra gli eventi conclusivi dell’Impero Romano (l’assedio di Pavia del 476 d.C. determinò la caduta di Flavio Oreste, padre di Romolo Augusto, ultimo imperatore romano d’Occidente, e la vittoria di Odoacre, e viene indicato rappresentativamente come inizio del Medioevo), il ruolo avuto da tale città come capitale del Regno dei Longobardi e più generalmente del Regno d’Italia fino al 1014 d.C., l’assedio di re Carlo Magno, sino all’incoronazione di re Federico Barbarossa (1155 d.C.), che a Pavia risiedette per circa 13 anni, nonno del Re Federico II di Svevia “stupor mundi”.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 Settembre 1860
In questa data fu scritta una delle pagine storiche della storia della città di Bitetto, “la rivolta contro i signori”, che vide parte del paese assalire l’antica residenza della famiglia Fazio. La vicenda è raccontata personalmente nel testo “Bitetto nell’età borbonica” della scrittrice Rosa Antonacci De Marco, al cap. XVIII pagg. 404 – 405 – 406. Alcune ricostruzioni tenderebbero a far coincidere tale dimora in un edificio non più esistente su Via Beato Giacomo, all’epoca individuabile ai numeri civici 49 e 51, ove risiedeva in quel periodo Fazio Angelo Santo (vedasi albero genealogico), zio del protagonista del racconto. La restante parte del paese si è sviluppata successivamente.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Davide delle Cese
M.o Davide delle Cese, compositore italiano nato a Pontecorvo (Frosinone), è stato direttore d’orchestra a Venezia, San Leo e Bitonto.
Nel 1897 scrisse “L’Inglesina”, marcia dedicata ad una anonima ragazzina inglese, che ebbe un grande successo anche negli Stati Uniti, grazie all’opera di divulgazione del M.o Friedrich Fennel. È una tipica marcia concertistica italiana, suonata molto spesso al Sud, molto fresca e “cantabile”, con momenti drammatici. Oltre al ruolo avuto nella storia della musica per banda a livello internazionale, il M.o Davide delle Cese è noto per la riduzione in partitura di banda degli Inni Ufficiali di tutte le nazioni e gli stati civili del mondo.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Italo delle Cese
M.o. Italo delle Cese, compositore italiano, nato a San Leo, fu uno dei primi docenti del Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari e fondatore e primo direttore del Liceo Musicale Salentino, noto per la sua amicizia nonchè costante collaborazione con il tenore Tito Schipa, il M.o Nino Rota e il M.o Renzo Rossellini. Con il M.o. Nino Rota collaborò strettamente alla composizione del melodie per il film Gattopardo (es. Giovani Eroi – Marcetta), di alcuni film del regista Federico Fellini come “Giulietta degli spiriti” e “Dolce Vita” (es. scena del Club Cinese – Ritmi Tibetani) e Waterloo, brani ufficialmente registrati e tutelati in SIAE. Nel 1929 fu fondatore e primo direttore dell’Orchestra Stabile di Bari.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Casa dei Cavalieri di Malta, nota anche come “Casa Fazio”
L’autorevole scrittore Edgardo Noya di Bitetto (discendente della famiglia Lannoy) definisce la Casa dei Cavalieri di Malta di Bitetto come “Casa Fazio” (Blasonario Generale di Terra di Bari – 1912). Oggi non esiste una spiegazione ufficiale di tale definizione, utilizzata soprattutto nella maggior parte delle guide turistiche straniere. Una ipotesi potrebbe essere collegata all’epigrafe riportata sulla Casa dei Cavalieri di Malta, “Intrent securi qui querunt vivere puri”, la quale riproduce un celebre emistichio federiciano scolpito sull’antica Porta di Capua, distrutta nel 1557 (periodo che dovrebbe coincidere con quello dell’arrivo della famiglia a Bitetto). A Capua infatti risulta ancor oggi esserci Palazzo Fazio dove è collocato il Fazio Open Theater. Di Capua fu anche Pompeo Lanza, diplomatico italiano al servizio di Bona Sforza, trasferitosi a Bari nello stesso periodo della distruzione di Porta di Capua. E a Capua, avamposto più settentrionale del Regno di Sicilia, sorgeva una delle tre grandi sedi priorali dell’Ordine Melitense nell’Italia Meridionale.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bartolomeo Facio
Bartolomeo Facio/Fazio (c. prima del 1410 – 1457, ritratto in basso ms. Urb. lat. 415 della Bibl. apost. Vaticana), latinizzato come Bartholomaus Facius, è stato uno storico, scrittore, notaio italiano e una delle figure di riferimento dell’Umanesimo italiano.
È in corso un mio lavoro personale di ricerca per comprendere se eventuali discendenti si siano trasferiti da Napoli a Palo del Colle durante il periodo del Ducato di Bari con Isabella d’Aragona (1501-1524), una delle ipotetiche donne che si ritiene possano essere state rappresentate nella Gioconda di Leonardo da Vinci. Lo scrittore fu consigliere e segretario di Stato di Alfonso V D’Aragona. Considerando che il Ducato di Bari ebbe fine nel 1558, è possibile considerare questa data come il trasferimento della famiglia Fazio da Palo del Colle a Bitetto. Lo storico Kristeller ha creduto di identificare la moglie, che avrebbe sposato nel 1444, in una figlia di Ambrogio di Negro da Salerno, dalla quale avrebbe avuto un figlio, Giovanni.
Bartolomeo Facio morì a Napoli verso la fine del Novembre 1457. Fu sepolto nella Chiesa di Santa Maria Maggiore, ma ben presto del luogo della sua tomba si perse notizia.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lanfranco de Facii
Lanfranco (XI secolo – XII secolo) è stato un architetto italiano di età romanica, la cui attività è documentata dal 1099 nel duomo di Modena, unica opera a lui attribuibile con certezza. Il suo nome è citato, in rapporto alla progettazione del duomo, in un codice del XIII secolo conservato a Modena e nell'epigrafe commemorativa murata nell'abside del duomo stesso. Il nome di Lanfranco, evidentemente un maestro già rinomato al momento dell'incarico da parte dei modenesi, ritorna nell'epigrafe marmorea murata nell'abside maggiore del duomo, incisa nel periodo del massaro Bozzalino (1208-1225), ma i cui versi risalgono anch'essi al tempo di Aimone e più precisamente al 1106, anno della consacrazione dell'altare di San Geminiano. Vi si legge: «Lanfranco, illustre per impegno, dotto e capace è il protomastro e il direttore dell'edificio».
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _